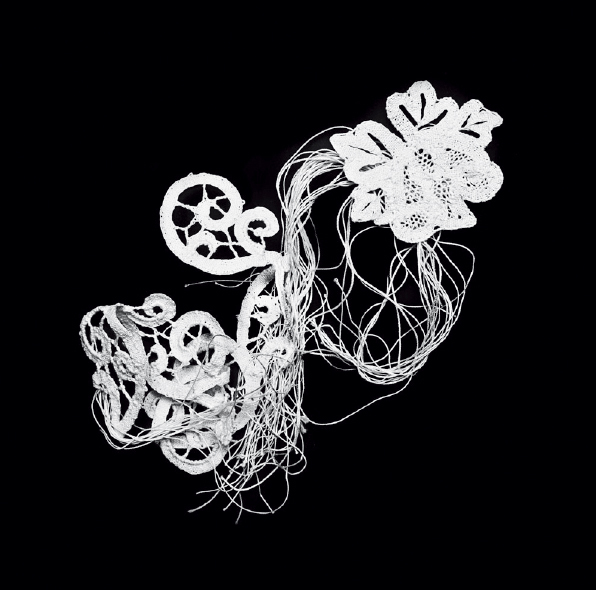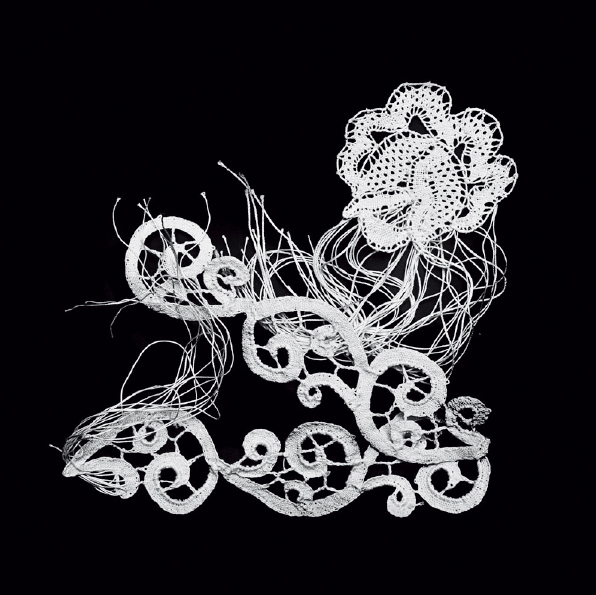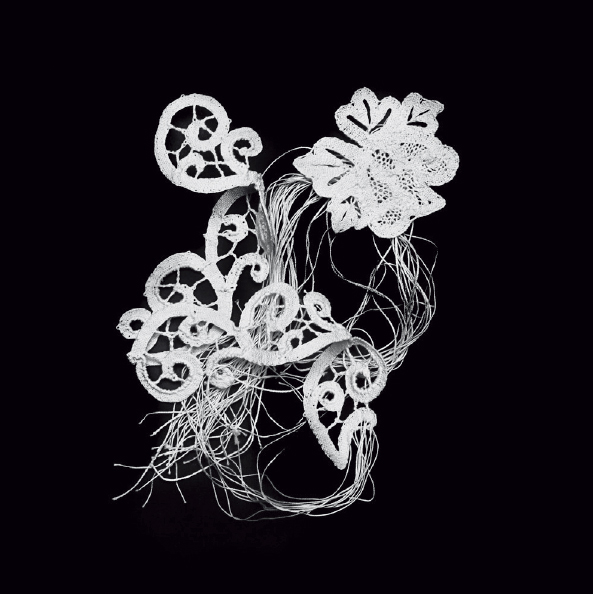Prezioso e semplice, esile e denso,
il filo che diventa pizzo, trina, trama
scorre tra i punti più profondi
dell’esistere nel mondo.
Si lega e si intreccia al sentimento
della casa, della famiglia,
di rituali condivisi e diventa mappa
su cui scrivere e riscrivere
stagioni e raccolti, feste e destini.
Il pizzo è appartenenza
a un luogo e a una terra.
La terra dei fiori di campo e delle rose,
delle vecchie case, che punteggiano
le colline di piccoli occhi,
delle campane a festa
e dei filari di vite, geometrici e fantasiosi
di foglie frastagliate, di grappoli tondi,
di viticci a cerchi e a spirali.
E come i roseti, da sempre
coltivati accanto a ogni filare,
a vegliare la forza della terra
e la salute delle viti,
i pizzi incarnano una bellezza
che protegge e salva,
preghiera laica recitata senza parole
nelle corti, nelle aie e davanti al fuoco.
Una preghiera che dice
che la vita è un filo di cotone,
da intrecciare e tessere e condurre
secondo strade tortuose di collina,
e misteriose di curve e ritorni.
Là ci sono i vuoti, qui ci sono i pieni,
là le rose, qui le viti, più in fondo
le salite e i bordi arrotondati.
Qui il filo si tende, là si ammorbidisce,
qui si divide, lì si torna a unire.
È per questo, forse, che è il pizzo
a vestire le giovani spose di maggio,
i bimbi appena nati,
la pelle nei suoi luoghi più segreti,
le vecchie donne in preghiera,
i piccoli altari domestici.
E anche questa bottiglia.
testo di Giulia Capotorto